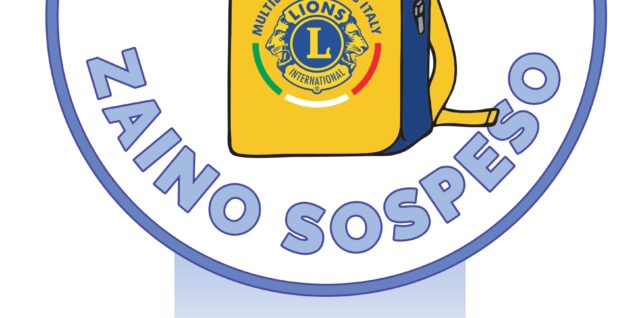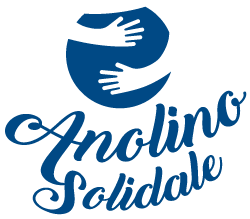L’Emporio solidale valtaro augura a tutti Buone Feste!

Un augurio di pace e serenità a Voi e alle Vostre famiglie.Per l’Emporio Solidale Valtaro il 2026 sarà un anno di grandi progetti, che richiederanno il contributo di tutti coloro che vorranno sostenere il percorso di solidarietà che stiamo portando avanti. Il mondo attraversa un momento di profonda difficoltà: la violenza della guerra tuona alle porte dell’Europa e la forza, fisica ed economica, ha preso il posto della diplomazia e del confronto. In questo contesto, i diritti delle persone – soprattutto dei più deboli – vengono messi in discussione. Sono storie antiche, che pensavamo relegate al passato, ma che invece continuano a seguire l’uomo come un’ombra. È proprio per questo che ogni progetto di solidarietà e di vicinanza alle persone, in particolare ai più fragili – bambini, anziani, profughi, migranti – rappresenta un valore prezioso, da coltivare e difendere. Ne va della nostra umanità. BUONE FESTE!